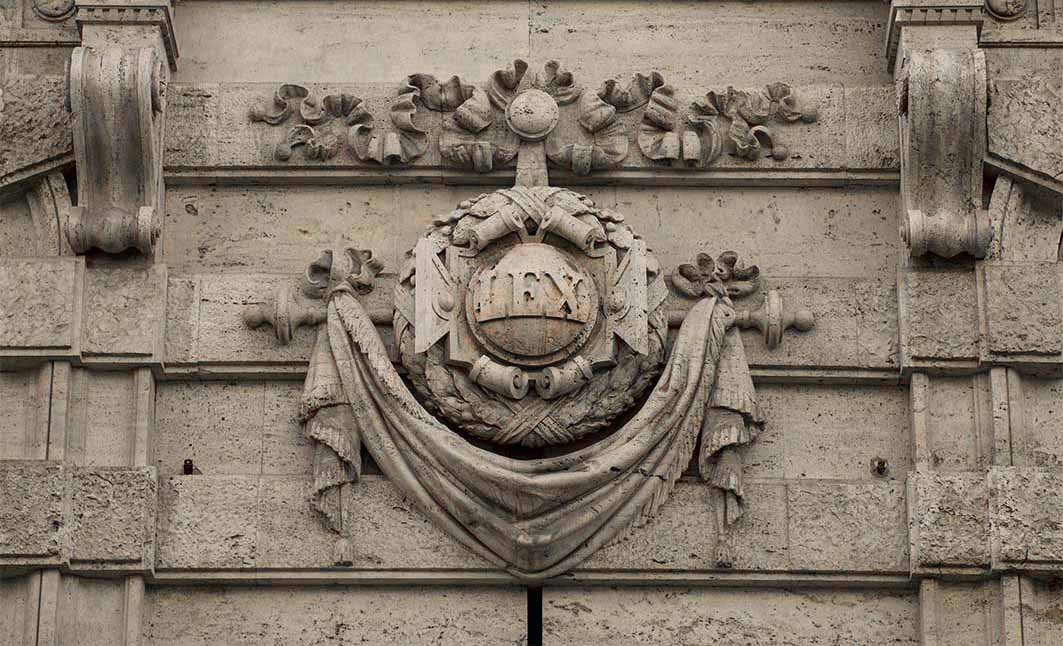La prima delle due sentenze (n.20540) ha chiarito che “quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di insussistenza del fatto contestato”, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione”, precisando (in termini integrativi rispetto al primo pronunciamento della Corte di Cassazione, risalente alla sentenza 6 novembre 2014, n. 23669)che“la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell’articolo 18, quarto comma, cit.”.
In tal modo, con la prima pronuncia, la Corte di Cassazione ha asserito un principio “minimale”, scongiurando l’ipotesi per cui un licenziamento disciplinare, intimato per un comportamento lecito del dipendente (effettivo), possa essere giudizialmente dichiarato illegittimo, per difetto di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ma sia comunque ritenuto produttivo di effetti.
La seconda sentenza (n. 20545) ha statuito che si configura l’applicazione della tutela reintegratoria dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, anche qualora la fattispecie di illecito configurata dalla legge o dal contratto, cui abbia fatto riferimento il datore di lavoro nella contestazione di addebiti posta a base del licenziamento, si sia realizzata soltanto in parte e, quindi, nel caso in cui solo alcuni degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito disciplinare richiamata abbiano trovato dimostrazione in giudizio da parte del datore di lavoro.
La sentenza n. 20540/2015
Con la prima delle due sentenze in commento, n. 20540, la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte di appello di Milano, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice e condannato l’azienda alla reintegra nel posto di lavoro ai sensi del vigente articolo 18, comma 4, dello “Statuto dei Lavoratori”.
Detto licenziamento poggiava su una contestazione articolata in quattro punti, evidenzianti secondo l’azienda un atteggiamento “persecutorio e vendicativo” della lavoratrice nei confronti dell’amministratore delegato: a) l’avere proferito la dipendente parole risentite nei confronti del superiore, con le quali ne aveva messo in dubbio la correttezza e il rispetto dei valori aziendali; b) la mancata risposta al direttore finanziario che la invitava ad esaminare la sua posizione ed a discutere direttamente con l’amministratore delegato dell’azienda; c) l’avere segnalato ad altro dirigente della società l’intenzione dell’AD (di cui la lavoratrice avrebbe avuto notizia in modo asseritamente non autorizzato) di volere cambiare azienda; d) il non avere restituito un apparecchio telefonico posto in dotazione dall’azienda.
La Corte di appello di Milano aveva ritenuto il primo addebito tardivo, il secondo addebito non contrastante con la disciplina di impresa, il terzo e il quarto sostanzialmente insussistenti (la lavoratrice aveva appreso direttamente dall’amministratore delegato le proprie intenzioni e non aveva mai rifiutato la restituzione del telefono).
La società ricorrente aveva censurato la sentenza della Corte di Appello per non avere valutato, nella loro complessità, i comportamenti della lavoratrice e per avere applicato la disciplina reintegratoria dell’articolo 18, comma 4 citato, benché i fatti contestati fossero risultati sussistenti.
La Corte di Cassazione, preso atto della mancata censura, ad opera della parte ricorrente, del capo di sentenza che aveva considerato la tardività del primo addebito, ha confermato la statuizione della Corte di appello anche laddove aveva ritenuto gli ulteriori fatti contestati insussistenti o privi di rilievo giuridico, poiché unicamente contrari alle “regole della compostezza e degli usi mondani” e, pertanto, giuridicamente non rilevanti.
La Suprema Corte, con riferimento ai rimedi conseguenti alla ritenuta illegittimità del licenziamento, ha osservato che “quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di insussistenza del fatto contestato”, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al presente caso la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva (Cassazione 6 novembre 2014, n. 23669, che si riferisce ad un caso di insussistenza materiale del fatto contestato). In altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell’articolo 18, quarto comma, cit.”.
Il fatto (materiale) contestato deve essere illecito
La Corte di Cassazione, in tale prima sentenza, chiarisce che la tutela reintegratoria di cui all’articolo 18, comma 4, citato, debba trovare applicazione nelle ipotesi in cui il fatto materiale contestato, seppur sussistente, si sia rivelato privo del carattere della illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, e, quindi, sia irrilevante dal punto di vista giuridico. In altri termini, l’irrilevanza giuridica del fatto contestato, la sua inidoneità ad essere qualificato come inadempimento o condotta illecita, impedisce che possa esso configurarsi come “fatto materiale sussistente” ai sensi dell’articolo 18, comma 4.
Tali precisazioni integrano, senza contraddirle, le indicazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Cassazione 6 novembre 2014, n. 23669, nella cui motivazione si leggeva che “Il nuovo articolo 18 ha tenuto distinta, invero, dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, sicché occorre operare una distinzione tra l’esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato”.
I chiarimenti integrativi forniti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20540/2015 sanciscono un principio “minimale”, scongiurando l’ipotesi – francamente aberrante e in palese contrasto con i principi generali in materia di obbligazioni contrattuali e di risoluzione per inadempimento – per cui un licenziamento disciplinare, intimato per un comportamento lecito del dipendente (rivelatosi effettivo), possa essere giudizialmente dichiarato illegittimo, per difetto di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ma sia comunque ritenuto produttivo di effetti (determinando la risoluzione del rapporto lavorativo), con solo obbligo del datore di lavoro di versamento della indennità risarcitoria nella misura determinata dall’articolo 18, comma 5 dello “Statuto dei Lavoratori”, come novellato dalla “Legge Fornero”.
Va, peraltro, rimarcato che la sentenza prende espressamente in esame l’ipotesi, presumibilmente residuale, di intimazione di un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo per comportamento del dipendente pienamente lecito, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, precisando tuttavia che resta “estranea al caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta rispetto alla sanzione espulsiva (Cassazione 6 novembre 2014, n. 23669, che si riferisce ad un caso di insussistenza materiale del fatto contestato). In altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell’articolo 18, quarto comma, cit.”.
Per il diverso caso del licenziamento intimato a fronte di un inadempimento di lieve entità o, in altri termini, di un fatto materiale di modesta illiceità, stante la rilevanza disciplinare del comportamento contestato al lavoratore, rimangono ferme le indicazioni contenute nella citata sentenza della Corte di Cassazione 6 novembre 2014, n. 23669, che escludono l’accesso alla tutela reintegratoria, quanto meno per assenza del presupposto della “insussistenza del fatto contestato” (di cui all’articolo 18, comma 4, più volte citato).
L’accesso alla tutela reintegratoria dell’articolo 18, comma 4 citato rimane possibile nella diversa ipotesi ivi prevista (che invece non è stata reiterata nell’articolo 3, comma 2, Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, applicabile agli assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, per i quali non opererà questa “clausola di salvaguardia”)di licenziamento intimato per condotte che, per contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o codice disciplinare applicabile, sarebbero state passibili solo di sanzione conservativa. Sotto tale profilo, la “modesta illiceità” del comportamento contestato può rilevare, ai fini dell’applicazione della tutela reintegratoria in questione, solo in quanto vi sia (aspetto da verificare caso per caso) una espressa menzione del comportamento contestato nel contratto collettivo applicato dall’azienda, con positiva previsione per esso della sanzione conservativa.
La sentenza n. 20545/2015 – fatto contestato e “fattispecie di illecito disciplinare”
La Corte di Cassazione, nella seconda sentenza in commento, n. 20545/2015, aveva ad oggetto un licenziamento intimato da una azienda telefonica nei confronti di un dipendente con riferimento alla fattispecie dell’articolo 48, lettera b, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore (“CCNL”), che prevede il licenziamento per fatti arrecanti all’azienda “grave nocumento morale o materiale”.
La Corte di Cassazione, in tale seconda pronuncia, nel rilevare che la Corte di appello di Roma non aveva proceduto ad un accertamento dei fatti costituenti il grave nocumento morale o materiale e ciò nonostante avesse ritenuto questi “provati a sufficienza” e “sussumibili nella fattispecie dell’articolo 48, lettera B” del “CCNL”, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata ed ha precisato che “tale nocumento grave è parte integrante della fattispecie di illecito disciplinare in questione onde l’accertamento della sua mancanza determina quella insussistenza del fatto addebitato al lavoratore, prevista dall’articolo 18, legge 300 del 1970, mod. dall’articolo 1, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92, quale elemento costitutivo del diritto al ripristino del rapporto di lavoro. Questo elemento deve infatti considerarsi esistente qualora la fattispecie di illecito configurata dalla legge o dal contratto sia realizzata soltanto in parte”.
Queste affermazioni sembrerebbero mettere in discussione la valenza materiale del “fatto contestato”, laddove viene conferito rilievo alla “fattispecie di illecito disciplinare” quale previsto dalla legge o dal contratto collettivo.
Tuttavia, anche attesa la posizione espressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20540, resa nel medesimo giorno, sembra più logico ritenere che la Corte abbia voluto precisare che, nei casi in cui il fatto contestato dal datore di lavoro sia “costruito” in aderenza ad una specifica fattispecie di illecito disciplinare, prevista dal contratto collettivo o dalla legge, – ferma l’indagine sulla sussistenza del fatto nella sua materialità – la fattispecie assume rilievo, imponendo che tutti gli elementi costitutivi di essa debbano essere riscontrati nel caso concreto (quindi provati dal datore di lavoro). In difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie, che abbiano trovato espressione nella missiva di addebito disciplinare rivolta al dipendente, il fatto contestato dovrà intendersi insussistente.
La Corte di Cassazione, rilevato che la fattispecie di illecito disciplinare in questione imponeva, tra i suoi elementi costitutivi, “il grave nocumento morale o materiale” oltre alla condotta inadempiente o negligente, ha ravvisato l’erroneità della pronuncia di secondo grado che tale danno aveva ritenuto provato, a dispetto di un adeguato accertamento sul punto.
Anche la pronuncia in esame, in questa chiave di lettura (coerente del resto alle indicazioni rinvenibili nella sentenza n. 20540), sembra riconfermare la indicazione già fornita dalla sentenza 6 novembre 2014, n. 23669 del “fatto contestato” quale fatto materiale (purché illecito).
Merita di essere rimarcato, peraltro, il secondo passaggio della motivazione sopra sottolineata. Laddove un comportamento sia stato contestato ad un dipendente in relazione ad una fattispecie di illecito disciplinare che preveda la compresenza di diversi elementi costitutivi (nella specie, la condotta inadempiente o scorretta ed il danno), il fatto può dirsi sussistente solo se tutti gli elementi del fatto contestato abbiano trovato conferma in giudizio.
Nel caso in esame, pertanto, la prova solo della condotta, ma non del grave nocumento, dando luogo ad insussistenza del fatto contestato (passaggio questo certamente meritevole di sottolineatura), determina l’applicazione, stando alle indicazioni della Corte di Cassazione, della tutela reintegratoria di cui all’articolo 18, comma 4, citato.
Del resto, una conferma di tale lettura della pronuncia in esame sembra evincersi dal fatto che la sentenza in questione, nel dichiarare l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso formulato dal lavoratore ricorrente, con il quale lo stesso si doleva che la Corte di appello non avesse ritenuto i fatti allo stesso contestati sussumibili nella fattispecie di cui all’articolo 47 del “CCNL” di settore (che prevede una sanzione conservativa), ha tra l’altro precisato che “la fattispecie di illecito delineata dall’articolo 47 cit. non venne contestata al lavoratore ed è perciò estranea al tema disputato in questo processo”. Come dire che bisogna sempre avere riguardo ai fatti quali cristallizzati dal datore di lavoro nella missiva di addebito.
Conclusivamente, il fatto (materiale) contestato deve essere illecito e, per essere ritenuto sussistente, deve essere provato in tutti i suoi elementi costitutivi, ove riferito ad una specifica fattispecie di illecito contrattuale.
Osservazioni in proiezione sul Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23
Come è noto, la citata decisione della Corte di Cassazione 6 novembre 2014, n. 23669 ha orientato le scelte adottate nel Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183), il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che la tutela reintegratoria trovi ingresso “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”.
Per tale ragione, è lecito presumere che le sentenze n. 20540 e 20545/2015, nei passaggi relativi agli ambiti di applicazione della tutela reintegratoria di cui al vigente articolo 18, comma 4 dello “Statuto dei Lavoratori”, si manifestino rilevanti, in proiezione, anche per la futura interpretazione dell’articolo 3, comma 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 e dell’espressione “insussistenza del fatto materiale contestato”, ivi riportata.
Se le indicazioni contenute nella sentenza n. 20540/2015 (sulla necessaria illiceità del fatto materiale contestato) appaiono esportabili anche ai licenziamenti intimati a personale destinatario del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, più problematica appare l’estensione dei principi contenuti nella seconda sentenza, n. 20545/2015.
L’articolo 3, comma 2, riportato (a differenza dell’articolo 18, comma 4 citato) addossa al lavoratore l’onere di “dimostrare direttamente l’insussistenza del fatto materiale contestato”, a dispetto del pacifico onere datoriale di dimostrare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo (articolo 5 della Legge 15 luglio 1966, n. 604). Stanti le precisazioni contenute nella sentenza n.20545/2015 sull’onere datoriale di dimostrazione del fatto contestato in tutti i suoi elementi costitutivi, non è da escludere che la giurisprudenza fornisca una lettura della norma di cui all’articolo 3, comma 2, citato, tale da ridimensionare la portata dell’onere probatorio a carico del lavoratore.
- Sulla modifica unilaterale in peius delle mansioni dopo il Jobs Act e sulle prospettive di concreto utilizzo, a fronte dei presupposti formali e sostanziali di cui all’art. 2103, commi 2 e 5, c.c. - 24 Giugno 2019
- Agenzie di somministrazione e licenziamento per g.m.o.: sulla mancanza di occasioni di lavoro di cui all’art. 25 del CCNL di settore e sui riflessi nei giudizi di impugnativa di licenziamento. Oneri di allegazione e tipo di tutela applicabile - 13 Luglio 2017
- Agenzie di somministrazione e licenziamento per mancanza di occasioni di lavoro – Tribunale di Velletri, 29 luglio 2016, est. Falcione, e Tribunale di Roma, 2 novembre 2016, est. Pagliarini - 12 Maggio 2017
- Licenziamento – Tribunale di Larino: valutazione delle sanzioni richiamate ai fini della recidiva che ha dato luogo al licenziamento - 11 Maggio 2016
- Risarcimento – Cassazione SU Civili: risarcimento del danno spettante al dipendente pubblico in caso di abuso del contratto a tempo determinato - 25 Marzo 2016
- Licenziamento disciplinare: nuove indicazioni della Corte di Cassazione sulla “insussistenza del fatto contestato” e sulla conseguente applicazione della reintegra - 30 Ottobre 2015
- Applicazione al dirigente medico dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, per effetto del CCNL ARIS ANMRIS sulla valenza delle dichiarazioni confessorie rese in sede disciplinare - 19 Giugno 2015
- Eventus Damni ed onere della prova nella revocatoria ordinaria, tra il principio della garanzia patrimoniale e la libertà di iniziativa economica del debitore - 14 Febbraio 1999
- Lavoro all’estero: scelta della legge applicabile e limite dell’ordine pubblico interno - 25 Maggio 1998