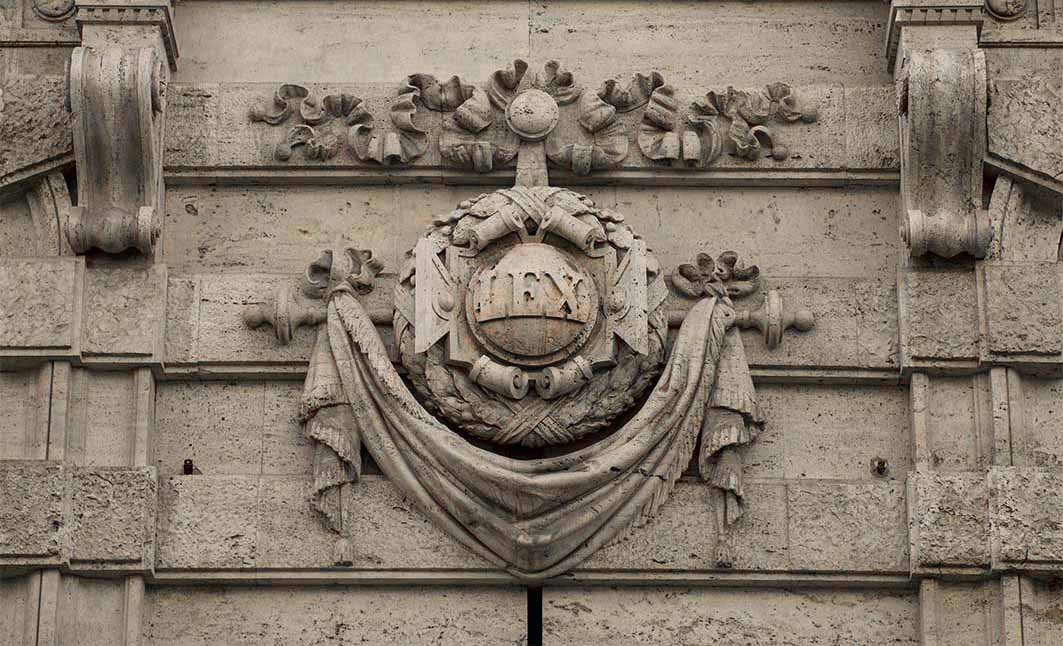La procedura di cui all’articolo 1, commi da 47 a 68 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetto Rito Fornero), pur destinata, negli originari auspici del Legislatore, ad evitare alcune incongruenze del precedente sistema processuale, ha creato, sin dalla sua introduzione, notevoli problematiche, preoccupazioni e complicazioni per gli avvocati e per i giudici.
Fin da subito gli operatori del settore, valutandone l’inopportunità, se non l’inutilità, ne hanno chiesto l’abrogazione, ipotesi recentemente fatta propria dall’attuale Legislatore tanto che, lo scorso 10 marzo 2016, la Camera dei Deputati, in sede di discussione sulla “Legge delega recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”, ha approvato un testo normativo che, quantomeno per il futuro, ricondurrà, con alcune modifiche, le cause di impugnativa di licenziamento alla disciplina ordinaria dell’articolo 414 del codice di procedura civile.
Prevedendosi ancora tempi non brevi per la seconda lettura del progetto di legge abrogativo, si dovrà ancora convivere, per qualche tempo, con la richiamata disciplina processuale.
In tale contesto, vale domandarsi quali siano state le ragioni che, nel 2012, hanno condotto il Governo Monti ad affiancare, con la Legge 28 giugno 2012, n. 92, la innovativa revisione della normativa sui licenziamenti e la radicale riscrittura dell’articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), con il nuovo complesso “rito”, destinato, nelle migliori intenzioni, a “velocizzare” le cause aventi ad oggetto le impugnative di licenziamento.
Ragioni dell’esigenza di celerità delle decisioni sui licenziamenti
Per comprendere la genesi, le caratteristiche e le ragioni dell’entrata in vigore del cosiddetto “Rito Fornero e dell’intero impianto della Legge n. 92 del 2012, occorre rammentare che, da sempre, la principale delle critiche formulate alla disciplina antecedente era quella che vedeva identificare la reintegrazione come l’unica forma sanzionatoria del licenziamento illegittimo, così come previsto dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300, introdotta nel lontano 1970 dal governo Rumor, allora in carica, e dal ministro del lavoro Donat Cattin, risultando con la stessa inibito al Giudice di modulare, a seconda delle situazioni, diverse ed intermedie ipotesi riparatorie di un errato recesso.
Prima dell’introduzione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e della “sanzione unica reintegratoria”, il sistema di riparazione dei licenziamenti illegittimi era di tipo indennizzatorio, secondo parametri definiti dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, prevedente solo una sanzione economica (indennità da 5 a dodici mensilità). Sotto il profilo rituale, la Legge n. 604/1966 aveva introdotto, ma solo per le impugnative dei licenziamenti, la competenza funzionale del Pretore (con tempi certamente più veloci rispetto alle cause del Tribunale a decisione collegiale) il quale, comunque, emetteva una decisione ancora con sentenza non provvisoriamente esecutiva.
Va ricordato che, per rivendicazioni dei lavoratori diverse dall’impugnativa dei licenziamenti, vi era ancora la competenza del Tribunale, i cui tempi di decisione erano già biblici, tanto che, nel periodo 1967-68 la durata media delle controversie in materia di lavoro era di 824 giorni in primo grado e di 634 giorni in secondo grado.
Anche per le sentenze di licenziamento, nel 1970, operava ancora l’effetto sospensivo dell’appello, per cui, in caso di condanna in primo grado, la parte beneficiaria di una sentenza, gravata di appello, doveva comunque attendere la pronunzia di secondo grado, con perdita economica secca, stante il non automatico riconoscimento della rivalutazione monetaria. La soddisfazione del diritto leso giungeva quindi mediamente dopo 1500 giorni dal licenziamento, con evidente interesse della parte convenuta, soprattutto se più forte economicamente, a trascinare ad libitum la procedura o a chiudere transattivamente con importi contenuti al ribasso.
Con lo Statuto dei Lavoratori, il Legislatore non solo previde la sanzione della reintegrazione e la provvisoria esecutività della sentenza, ma, a tutela economica del lavoratore ingiustamente licenziato, affiancò, al provvedimento di reintegrazione, la condanna ad un risarcimento del danno da licenziamento, con determinazione rimessa al Pretore in misura non inferiore a 5 mensilità, per cui, ove condannato alla reintegrazione, il datore di lavoro, con sentenza immediatamente esecutiva, subiva un peso risarcitorio di entità non prevedibile, generalmente superiore alla misura minima.
Pur con l’introduzione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e del drastico abbattimento dei precedenti tempi, continuava a sussistere un autentico e concreto interesse del lavoratore alla celerità della decisione, posto che, dovendo ipotizzarsi una sua potenziale futura reimmissione nel precedente posto di lavoro, allo stesso si imponevano scelte esistenziali importanti, non compatibili con tempi processuali lunghi.
Non potendo rimanere nell’incertezza circa il suo futuro lavorativo e circa l’ammontare del risarcimento, neppure gratificato di un automatico riconoscimento della rivalutazione monetaria, il lavoratore, spesso non attratto a rientrare in un ambiente non più psicologicamente gradito, preferiva non attendere, addivenendo a transazioni sfavorevoli.
La disciplina dei licenziamenti prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, pur con competenza pretorile e con provvisoria esecuzione della sentenza, venne subito posta in critico raffronto con la previsione, contenuta all’articolo 28 della stessa Legge n. 300/1970, che, per le cause di condotta antisindacale, prevedeva una procedura ancor più snella, ivi imponendosi al Giudice, nei due giorni successivi al deposito del ricorso, di convocare le parti ed emettere un provvedimento sommario ed immediato, opponibile nei 15 giorni successivi.
La lunghezza del processo per impugnativa di licenziamenti evidenziava, quindi, ancora uno scollamento tra necessità di intervento sollecito a tutela del lavoratore e tempi di emissione della sentenza.
La Legge 11 agosto 1973, n. 533 istitutiva del processo del lavoro
A ciò pose un sensibile rimedio la Legge 11 agosto 1973, n. 533 (emanata in vigenza del Governo Andreotti, con Ministro di Grazia e Giustizia on. Gonella, Ministro del Lavoro on. Coppo), che, istituendo il rito del lavoro, con giudice unico identificato, per tutte le cause di lavoro, nel Pretore, contribuì notevolmente a velocizzare le decisioni, soprattutto quelle di impugnativa di licenziamento, cui, nell’organizzazione del lavoro delle Preture, venne da subito assegnata una corsia privilegiata.
La formulazione della legge era nei fatti improntata al raggiungimento di risultati inimmaginabili in termini di velocità, posto che, in essa, era previsto che il giudice, nei 5 giorni successivi al deposito della domanda, da formularsi sotto forma di ricorso, dovesse emettere un immediato provvedimento di fissazione dell’udienza, e che questa dovesse essere tenuta nel termine di 60 giorni.
Al comma 5 dell’articolo 420 del codice di procedura civile, era inoltre dato spazio determinante all’interrogatorio libero ed era prevista una pressoché immediata ammissione dei mezzi di prova, da assumersi, ove possibile, nella stessa udienza, o al più tardi in altra udienza da fissarsi nei giorni feriali immediatamente successivi. Il rinvio per la decisione era ammesso nel termine di dieci giorni, con facoltà delle parti di depositare note difensive nei cinque giorni precedenti.
Anche per l’appello era prevista la fissazione dell’udienza di discussione entro il termine di 60 giorni, con decisione generalmente immediata, stante l’improponibilità di nuove prove.
Come si vede, quindi, la normativa del processo del lavoro del 1973 prevedeva termini brucianti (primo grado ed appello in sei mesi) per cui, ove applicata nello spirito e nelle intenzioni del Legislatore, non avrebbe mai avuto ragione di essere sostituita con altra disciplina più veloce.
All’articolo 429 codice di procedura civile, era inoltre prevista, in caso di condanna al pagamento di somme in favore del Lavoratore, l’applicazione automatica della rivalutazione monetaria, con accentuazione dell’interesse alla velocizzazione anche da parte del datori di lavoro, sempre meno interessati a strategie difensive di trascinamento dei giudizi.
Naturalmente, la disciplina avrebbe avuto necessità di mezzi e di impegno degli operatori ed invero, unitamente alla sua approvazione, il Parlamento previde effettive dotazioni straordinarie di risorse e strutture.
Nonostante l’impegno di tutti gli operatori e gli stanziamenti compiuti per dar corpo ad un’autentica rivoluzione processuale (molti giudici presero effettivamente ad applicare alla lettera la procedura, emettendo decisioni in prima o seconda udienza, con discussione e lettura del dispositivo nella stessa giornata, con trattazione di cause sino a pomeriggio inoltrato), l’endemico allungamento dei tempi, stante la qualificazione di non perentorietà dei termini indicati dalla legge per i Giudici e la carenza di mezzi rispetto alla pesantezza dei ruoli, continuò ad impedire una concreta efficacia deterrente della reintegrazione.
Il meccanismo virtuoso infatti si inceppò molto presto, tenuto per di più conto che, a fronte della riconosciuta efficacia del rito e della percezione di concreto raggiungimento di risultati nella tutela dei diritti dei lavoratori, le Preture vennero presto investite da una valanga di ricorsi.
La legge del 1973 raggiunse comunque effetti notevoli, facendo comunque qualificare, nel panorama processuale italiano, la procedura del lavoro come la più organica ed efficace, tanto da essere adottata a modello da successive riforme del processo civile.
In tale contesto, stante la mancata attenuazione dei tempi lunghi delle decisioni, si è rimanifestato l’interesse alla velocizzazione da parte dei lavoratori, attenuato solo dall’orientamento di parte prevalente della giurisprudenza, che ha ben presto fatto coincidere l’ammontare del danno da licenziamento con tutte le mensilità intercorse tra lo stesso e la sentenza di reintegrazione.
La legge 11 maggio 1990 n. 108
Tale ultimo orientamento è risultato normativamente confermato con l’entrata in vigore della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Governo Andreotti e ministro del Lavoro Donat Cattin), che, in caso di declaratoria di illegittimità del recesso, oltre ad eliminare la previsione minima del danno, ha previsto, come automatica, l’applicazione di un’indennità di reintegrazione commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, unita al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per l’identico periodo, sostanzialmente equiparandosi il risarcimento a tutto quanto il lavoratore avrebbe percepito ove il rapporto non si fosse interrotto.
Con il tempo la combine di normativa, sostanziale e previdenziale, è andata a regime, con essa amplificando il metus del datore di lavoro, il quale ha sempre più percepito il forte rischio economico connesso al licenziamento di lavoratori, non tanto e non solo per la materiale reintegrazione, quanto per le conseguenze economiche di valenza risarcitoria che, in ragione dei tempi e delle incertezze della giustizia nei vari gradi di giudizio, venivano spesso, pur con l’attenuazione della prova dell’aliunde perceptum, a determinare condanne economicamente esplosive e poco sopportabili soprattutto per aziende di medie e piccole dimensioni.
I lavoratori, non sempre interessati all’effettivo ripristino del rapporto, ma attratti dalle cospicue cifre delle condanne risarcitorie, si sono quindi trovati in posizione privilegiata, quantomeno in caso di trattative economiche, e ciò nella consapevolezza che, lungi dal costituire una componente di loro debolezza, la lunghezza dei processi veniva a costituire un elemento di forza contrattuale.
Per di più, non prevedendo la legge oneri decadenziali nella presentazione dei ricorsi, non si escludevano situazioni di attesa tattica dei lavoratori, finalizzate, soprattutto in caso di difficile prova dell’aliunde perceptum (onere giurisprudenzialmente addossato al datore di lavoro) a far valere detta opportunità in funzione degli effetti geometricamente esponenziali del danno ottenibile.
La giurisprudenza (significativa è quella nel tempo adottata dalla Corte d’Appello di Roma) ha preso, quindi, concretamente in esame casi di effettivo ritardo nella presentazione dei ricorsi e, anche utilizzando la previsione dell’articolo 1227 del codice civile, ha ritenuto procedere a forme di attenuazione del danno (ad esempio equitativamente limitato a tre annualità), non previste dal Legislatore, che altrimenti, con la previsione automatica della Legge 11 maggio 1990 n. 108, avrebbe raggiunto contenuti abnormi, aggravati in molte situazioni dalla facoltà, concessa unilateralmente al lavoratore, di rinunziare alla reintegrazione, con la monetizzazione della stessa nella misura fissa di 15 mensilità retributive.
Nei fatti, anche il lavoratore, pur come detto potenzialmente gratificato, in alcuni casi, dalla lunghezza dei processi, aveva comunque ampi motivi per dolersi del sistema, sia per i tempi ormai divenuti molto lunghi per ottenere, ove spettante, la reintegrazione, sia per l’incertezza collegata alla natura precaria della ricostituzione del rapporto, soggetta alle successive verifiche di appello e di cassazione, sia per la concreta possibilità, in caso di riforma della sentenza di primo grado, di dover subire, oltre all’estromissione dal posto di lavoro, il peso, a volte drammatico, della restituzione di gran parte delle somme percepite provvisoriamente.
In presenza della mancata realizzazione dei risultati auspicati dal Legislatore con l’introduzione della disciplina ordinaria del lavoro, è stata in molti casi utilizzata la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 700 del codice di procedura civile che, pur a fronte dell’emissione di numerosi provvedimenti anticipatori, non ha tuttavia mai potuto erigersi a sistema, soprattutto a fronte della necessità di prova del pregiudizio irreparabile, elemento generalmente ritenuto inesistente in re ipsa per lo stato di disoccupazione del lavoratore ricorrente. Significativa è la circostanza che quasi sempre, in caso di proposizione di ricorso d’urgenza, le parti datoriali, pur fisiologicamente interessate ad un veloce accertamento sulla legittimità del licenziamento, costituendosi in giudizio, hanno eccepito la non ritualità della procedura d’urgenza, non solo deducendo l’inesistenza del periculum, ma soprattutto invocando l’esistenza della specifica, alternativa procedura del lavoro, dotata di formali tempi brucianti, ricevendo in ciò conforto da parte di molti giudici.
È stato così che, soprattutto da parte datoriale, stante l’impraticabilità politica di veder modificato l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori con adozione di forme sanzionatorie diverse dalla reintegrazione nel posto di lavoro, sono stati invocati interventi normativi atti a contenere in qualche modo gli oneri risarcitori conseguenti alle lungaggini processuali e ciò con interventi che, in qualche modo, realizzassero una sollecita definizione del contenzioso.
Il legislatore ha così tentato con varie iniziative di arginare il problema, prevalentemente costituito dal numero rilevante di cause di lavoro, introducendo forme di deflazione del ricorsi giudiziali.
Norme di deflazione del contenzioso
Si ricordano i vari tentativi di ridurre il numero delle cause di lavoro compiuto con forme agevolative delle conciliazioni, tutti falliti, soprattutto per l’omessa previsione normativa di forme preventive obbligatorie o contemplanti un autentico interesse di entrambi le parti di parteciparvi, nonché per l’assenza di forme premiali economicamente incentivanti e per la mancata previsione di sanzioni a carico della parte illogicamente indisponibile ad un accordo.
Significativamente, anche il tentativo di condizionare la procedibilità delle cause di lavoro al preventivo esperimento di una procedura conciliativa presso la DPL, introdotta dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.80, si è rivelato, nei fatti, un costoso ed inutile adempimento burocratico ed una ulteriore forma di appesantimento nei processi, gravati di eccezioni e verifiche aggiuntive in ordine all’avvenuto corretto esperimento preventivo.
Nella ricerca di ipotizzare forme di velocizzazione, tra il Ministero del Lavoro e il Ministero di Giustizia si è così tentato un nuovo approccio processuale, sfociato, nel 2000, nell’istituzione della “Commissione Foglia”, e nel relativo progetto/proposta, prevedente un «peculiare rito accelerato a cognizione sommaria, ma non superficiale, il regime di reclamabilità ed impugnabilità dell’ordinanza, con l’introduzione di una misura coercitiva sul modello dell’astreinte, a garanzia dell’ottemperanza all’ordine giudiziale di reintegrazione, la priorità nella trattazione di siffatte controversie».
A seguito della formulazione dei risultati della relazione Foglia, sono seguiti diversi progetti di legge finalizzati all’istituzione di una procedura accelerata per le cause di licenziamento, ma nessuno di tali progetti è approdato alle commissioni parlamentari.
La situazione, già pesante per le aziende ed aggravatasi dopo i segnali di crisi internazionale conseguenti al 2008, ha visto una prima, timida, risposta del legislatore con la Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Governo Berlusconi, Ministro del Lavoro Sacconi), nella quale, ai fini di contenimento dei tempi processuali, è stato, per la prima volta, definito un termine entro cui, dopo la impugnativa, dovesse essere depositato il ricorso finalizzato ad ottenere la reintegrazione, termine dapprima indicato in 270 giorni, successivamente ridotto a 180 giorni dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92.
Neppure tale norma, che ha certamente ridotto l’anomalia dei ritardi “tattici” dei ricorsi, ha tuttavia consentito, in ragione dei tempi sempre lunghi dei giudizi, di ridurre più di tanto l’aggravamento degli oneri risarcitori a carico dei datori di lavoro, conseguenti al licenziamento dichiarato illegittimo, per cui il problema è risultato solo in minima parte attenuato.
Legge 28 giugno 2012, n. 92 – Riforma sostanziale dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e dell’introduzione di un nuova procedura per l’impugnativa dei licenziamenti.
La spinta fondamentale alla introduzione di una disciplina speciale e celere è venuta con la crisi che ha portato il governo Monti ad emanare la legge 28 giugno 2012 n. 92, notoriamente frutto della situazione di emergenza del 2011 e dei moniti dell’Europa che invitava l’Italia ad adottare una diversa normativa finalizzata ad attenuare i vincoli in caso di cessazione dei rapporti di lavoro, nel presupposto, ipotizzato da molti economisti già nel 1970, che “reintegrazione equivale recessione”.
Con questa legge, proprio in quanto adottata in emergenza e senza un vero confronto tra le parti politiche e soprattutto senza una dialettica con le parti sociali, sono state rimosse d’un sol colpo una serie di barriere precedentemente ritenute insuperabili, prima di tutte il tabù della sanzione unica della reintegrazione, ipotesi che, nella prima stesura, e quantomeno per i licenziamenti cosiddetti economici, era stata del tutto esclusa, ma che, nelle trattative parlamentari, è stata riconfermata, pur con limiti particolarmente stretti, soprattutto con riferimento al giustificato motivo oggettivo.
Non solo. La legge, al fine di attenuare le conseguenze delle condanne al danno riparatorio in caso di ritardo nella reintegrazione, salvi i casi eclatanti di licenziamento orale o licenziamento nullo, per i quali ha continuato a prevedere il pagamento di tutte le mensilità dal licenziamento alla reintegrazione, ha stabilito un limite alla sanzione risarcitoria, definibile, al massimo, in 12 mensilità retributive, ancorché appesantite dal versamento dei contributi.
Per le altre ipotesi, la legge, escludendo la reintegrazione, ha negato un danno da ritardo, prevedendo solo un’indennità risarcitoria (definibile in un range da 12 a 24 mensilità) ancorata a parametri oggettivi, ma non più collegata alla durata del processo.
Tale sistema, prevalentemente risarcitorio, unito alla determinazione di termini massimi per la presentazione del ricorso, ponendo fine alle situazioni che avevano condotto ai risarcimenti eccessivi collegati alla lunghezza dei processi, sarebbe stato, come è stato, di per sé sufficiente ad evitare le abnormità risarcitorie del passato, rendendo, nei fatti, superata l’esigenza di interventi modificativi della procedura del lavoro, che, come si è visto, almeno formalmente, era celere e semplice.
Nonostante ciò, il Legislatore del 2012, probabilmente nell’intento di strafare, ha ritenuto, con l’articolo 1, commi 47 e seguenti della Legge n.92, di introdurre comunque una nuova procedura che, ricalcando, anche se con molte differenze, il progetto della Commissione Foglia del 2002, ha cercato, ma solo sulla carta, di evitare, per le cause di licenziamento, alcune delle conseguenze collegate con il ritardo della giustizia.
Un siffatto intento emerge già dall’incipit di detta legge, ispirata, con varie modifiche dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, a stimolare l’occupazione. All’articolo 1, comma 1 sub. c) si annunzia infatti l’introduzione di “un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie”.
Nella relazione parlamentare di accompagnamento alla Legge si fa riferimento ad “un rito particolarmente snello, con una prima fase d’urgenza e con ampia discrezionalità del giudice nella gestione dell’istruttoria, con l’omissione di ogni formalità che egli ritenga non essenziale al contraddittorio. Già alla prima udienza, il giudice decide con ordinanza immediatamente esecutiva”.
Pur in presenza di tali nobili intenti, gli operatori del diritto del lavoro, ancorché intenti a valutare la portata sostanziale della Legge 28 giugno 2012 n. 92, non hanno omesso di dimostrare le più ampie perplessità per il nuovo rito, non solo in quanto lo stesso si sostituiva a forme processuali già formalmente veloci, ma soprattutto in quanto esso introduceva un doppio binario di vertenze, con una nuova fase sommaria che, anziché semplificare, avrebbe complicato molto le cause di impugnativa di licenziamento.
Con il “Rito Fornero” veniva infatti introdotta, e solo per giudizi di impugnativa del recesso, una procedura che si discostava dai canoni processuali ormai consolidati, con la sostanziale divisione del giudizio di primo grado in due fasi, una sommaria e l’altra di eventuale opposizione, finalizzato ad ottenere comunque una decisione precaria nel breve, ma a costo di notevoli incongruità.
Tra esse vennero immediatamente evidenziati: la sostanziale introduzione di quattro gradi di giudizio; la complessa definizione dei casi di applicabilità del rito; le varie difficoltà di scelta processuale della parte ricorrente; la sostanziale impossibilità di formulare delle domande subordinate per ipotesi di impugnativa non riconducibili all’articolo 18 L. 300/70; l’impossibilità di accorpare più domande in un unico ricorso; la non esperibilità della procedura preventiva da parte del datore di lavoro; la varietà di opzioni cui il giudice deve far fronte in caso di ricorso non correttamente introdotto; la problematica della conoscibilità dell’opposizione da parte del giudice assegnatario della fase sommaria.
Pur a fronte di tali comprensibili complicazioni e difficoltà processuali, la nuova procedura è entrata a regime, obbligando gli operatori (avvocati e giudici) a condividerla ed a conviverci, cercando, quantomeno, di ottenere, con la ipotizzata maggior sollecitudine, ed a scapito di cause di altra natura, più celeri ordinanze e sentenze provvisoriamente esecutive sulle impugnative ex articolo 18.
La Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sulle finalità di accelerazione della disciplina, non ha potuto che ribadire come la nuova normativa fosse finalizzata ad accelerare questo tipo di controversie e ridurre i costi indiretti derivanti dalla durata del processo.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza Ordinanza Cass. S.U. n.19674 del 18.9.2014, Accademia di Francia, ha statuito che “Il rito speciale è finalizzato all’accelerazione dei tempi del processo, nonché della stessa proposizione dell’impugnativa, avendo il legislatore voluto che la questione della reintegrazione – e più in generale dell’impugnativa del licenziamento per l’accesso alle tutele di cui all’articolo 18 cit. – sia subito portata innanzi al giudice e decisa in tempi rapidi”.
In tal senso possono richiamarsi altre numerose pronunzie, anche di legittimità, tra cui l’ordinanza della Corte di Cassazione 20 novembre 2014, n. 24790 e le pronunce 17 febbraio 2015, n. 3136 e 11 novembre 2015, n. 23073.
Il dichiarato scopo della norma, almeno formalmente, è stato quindi quello di prevedere un procedimento più semplice e veloce per le controversie aventi ad oggetto le impugnative di licenziamento, accelerando, almeno processualmente, l’emissione di provvedimenti provvisori per la tutela del lavoratore, tenendo in primis presente l’interesse datoriale a non subire le onerose conseguenze di una declaratoria di illegittimità a distanza di un rilevante lasso di tempo dalla declaratoria stessa.
Da molte parti si è autorevolmente sostenuto che tale innovazione normativa, pur precedentemente invocata per risolvere le esigenza di celerità, è giunta tuttavia fuori tempo, quando, prevedendosi la reintegrazione solo per ipotesi numericamente marginali, gran parte delle patologie precedentemente riscontrate erano state fortemente attenuate.
La celerità del rito aveva infatti ragion d’essere soprattutto nei casi di richiesta reintegrazione e di pagamento delle mensilità di danno nelle forme previste dalla legge 11 maggio 1990 n. 108 (al fine di fugare le incertezze del lavoratore da un lato ed i rischi economici esponenziali del datore), mentre si manifestava meno essenziale per le altre ipotesi sanzionatorie aventi ad oggetto una monetizzazione del recesso illegittimo.
Uno dei modi di superamento delle maglie della nuova complessa procedura è stato identificato da alcuni (e tra essi il Presidente del Tribunale di Firenze espressosi in tal senso nelle “Linee Guida” del 17 ottobre 2012 o il Tribunale di Napoli in sentenza 25 settembre 2013), nella ritenuta facoltà del lavoratore di utilizzare alternativamente anche la procedura ordinaria, e ciò considerando che la legge 92/2012 non si è espressa, in modo inequivoco, sulla obbligatorietà del rito.
La questione è approdata, nel panorama dottrinario e giurisprudenziale, a due differenti conclusioni, l’una improntata ad una disponibilità del rito del soggetto agente, l’altra escludente alcuna facoltà di scelta.
La linea improntata alla alternatività, oltre a richiamare l’inesistenza di un divieto espresso, ha fatto leva sulla giurisprudenza di legittimità espressasi sulla questione analoga in materia di condotta antisindacale, risolta con la sentenza 8.9.95 n. 9503, nella quale la Cassazione, ribadendo un precedente indirizzo, ha affermato che i soggetti legittimati ad esperire la speciale azione sommaria ex articolo 28 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 possono esercitare l’azione anche in via ordinaria nelle forme del rito speciale del lavoro.
Detta linea non è stata ritenuta persuasiva dalla prevalente giurisprudenza di merito che, per le ipotesi ritenute sussumibili nell’impugnativa dei licenziamenti rientranti nell’ambito dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, anche quando debbano essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, deve applicarsi inderogabilmente la disciplina dell’articolo 1, comma 47 e seguenti.
In tal senso, dopo un orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, è intervenuta anche la Suprema Corte con sentenza 11 novembre 2015, n.23073, ivi affermando l’impossibilità del lavoratore licenziato di rinunciare al rito speciale, non essendo stata la specialità prevista nel suo esclusivo interesse.
Secondo tale prevalente giurisprudenza, la obbligatorietà del rito risulta tecnicamente giustificata dalla preclusione per le parti di modificare o aggirare norme dettate per finalità pubblicistiche ed emanate nell’intento generale di assicurare comunque una decisione pressoché immediata alle impugnative di licenziamento, considerandosi sempre eventuale la fase di opposizione.
Al riguardo la Giurisprudenza ha ribadito che la procedura Fornero non costituisce un rito di natura cautelare, essendo avulso dal periculum in mora ed essendo strutturato per una cognizione sommariamente piena.
In tal senso la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la citata ordinanza 18.9.2014 n. 19674, ha affermato che “l’opposizione non è una revisio prioris istantiae, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario, con cognizione piena a mezzo di tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti”.
Reazioni degli operatori di Giustizia – Proposte di abrogazione del “Rito speciale Fornero”
Come sopra si è visto, in presenza di una precedente procedura del lavoro particolarmente orientata alla celerità, all’oralità e all’immediatezza, e verificato che gran parte delle anomalie e patologie non erano identificabili in difetti insiti nello schema processuale (che, salve poche crepe, dopo 43 anni di vigenza, è considerato ancora particolarmente moderno, utile ed efficace), bensì carenze di natura strutturale, di organizzazione e di mezzi, era arduo ritenere che la soluzione del problema potesse dipendere da una nuova modifica della procedura.
Immediatamente si è compreso che il “Rito Fornero” sarebbe stato fonte di una miriade di complicazioni procedurali in quanto, tra l’altro, non includente molte situazioni assimilabili al licenziamento (si pensi alle richieste di conversione di contratti a termine, al licenziamento in ipotesi di tutela obbligatoria, al licenziamento per superamento del comporto per malattia, al licenziamento dei dirigenti ecc.) e, soprattutto, in quanto ostativo alla proposizione di più domande con lo stesso ricorso, aspetto particolarmente delicato per gli avvocati, abituati, da sempre alla formulazione di più domande in un unico ricorso, spesso le une subordinate alle altre.
Ciò avrebbe inevitabilmente comportato, come nei fatti ha portato, alla duplicazione se non la proliferazione di giudizi, per di più accentuata dalla sostanziale previsione di quattro gradi di giudizio, due a cognizione piena, una sommaria e una di opposizione, con l’eventuale fase di reclamo e di cassazione.
Già dopo pochi mesi di vigenza della norma, ci si è resi conto che la stessa non avrebbe consentito alcuna particolare modifica del sistema o il raggiungimento di particolari risultati. Anzi, gli operatori hanno dovuto prendere atto che, a fronte di alcune oggettive accelerazioni, la maggior parte delle cause subivano rallentamenti imprevisti, a motivo di ordinanze interlocutorie, separazione di cause, rinvii per modifica del rito, per non parlare delle varie ipotesi di duplicazione, in primo grado, della medesima istruttoria (una nella fase sommaria e la seconda nella fase di opposizione), o della proposizione di giudizi separati in caso di rivendicazioni plurime dello stesso lavoratore, aspetti che probabilmente il Legislatore non aveva valutato con la dovuta ponderazione.
Un tale esito sarebbe stato comunque prevedibile, tenuto conto che, in carenza di mezzi e risorse particolari, era utopistico pensare di risolvere il problema con un mero maquillage procedurale.
Se si considera che, secondo la previsione dell’articolo 1, comma 69 della legge 92/2012, escludente stanziamenti aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate, può comprendersi come l’intento del legislatore di risolvere le problematiche di accelerazione delle cause di licenziamento con la panacea del nuovo rito speciale avesse ben poche chance di riuscita.
Alcune soluzioni introdotte dalla procedura in esame, anziché risolvere i problemi, contribuivano per di più ad aggravarle.
Va infatti considerato al riguardo che, al rito “ordinario” del lavoro, pur considerato ancora valido nel suo schematismo processuale, vengono già oggi generalmente addebitati alcuni sostanziali difetti, tra i quali: 1) la debolezza della posizione della parte ricorrente che, a seguito della costituzione del convenuto ex articolo 416 del codice di procedura civile, non ha la possibilità di replicare, nei dieci giorni intercorrenti dall’udienza, con la dovuta compiutezza, risultando allo stesso difficile articolare nel verbale dell’udienza di discussione, argomentazioni, controeccezioni, documentazione e istanze di prova a contrasto con le deduzioni del convenuto; 2) l’eccessiva incertezza per le parti di coniugare il potere dispositivo previsto dal codice con le iniziative spesso imprevedibili del giudice, legittimato ad intervenire nel processo soprattutto in termini istruttori, ammissivi o negatori di istanze di prova, con provvedimenti difficilmente recuperabili nelle fasi successive del processo; 3) la non chiara differenziazione tra interrogatorio formale e interrogatorio libero, con utilizzazione da parte dei giudici di alcune frasi, spesso verbalizzate in modo non formale o fuori contesto, come capisaldi in fatto su cui ancorare la motivazione del provvedimento; 4) l’uso non chiaro, a volte debordante e spesso sbilanciato, del principio di prova acquisita per mancata contestazione.
Ebbene, nel “Rito Fornero”, tali difetti risultano tutti accentuati, essendo stato addirittura ridotto a cinque giorni il termine strettissimo a difesa per il ricorrente, quantomeno nella prima fase del giudizio.
Per quanto riguarda gli interventi istruttori, l’interrogatorio e la mancata contestazione, il possibile intervento imprevisto del magistrato è stato addirittura accentuato, risultando concesso al giudice, sia nella fase sommaria che nella fase di opposizione, di procedere, nel “modo ritenuto più opportuno”, agli atti di istruzione indispensabili, richiesti dalle parti o disposti d’ufficio ex articolo 421 del codice di procedura civile.
Tali accentuate incertezze, unite alle difficoltà nella presentazione del ricorso e al prevedibile allungamento dei tempi per giungere al giudicato, hanno immediatamente spinto molti interpreti ed operatori a chiedere una abrogazione della procedura.
Le critiche procedurali, in un primo tempo, si sono sommate alle critiche all’intero impianto della legge, considerata nel complesso troppo penalizzante per la posizione dei lavoratori. I sostenitori della utilità dell’impianto sostanziale della Legge n. 92/2012, l’hanno fortemente difesa per questo profilo, unendosi, tuttavia agli altri per l’eliminazione di un rito, ritenuto inutile, con progressiva emersione di una critica unitaria degli avvocati di ogni parte e degli stessi magistrati.
Proposte di abrogazione
Tra le ipotesi di modifica va menzionata quella articolata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma nel 2013, nella quale non solo era richiesta una eliminazione dei commi da 47 a 69 della legge Fornero, ma, al fine di evitare il mantenimento, per anni ed anni, di un doppio regime, richiedeva di disciplinare i processi in corso, prevedendo una forma di riassorbimento delle cause pendenti introdotte con la procedura speciale, con riconduzione delle stesse alla disciplina ordinaria, al fine di evitare che la legge, pur essendo entrata in vigore da solo un anno, avesse ripercussioni, con trattamenti differenziati di cause per anni ed anni in avvenire.
È da menzionare inoltre una parallela iniziativa, meno articolata, portata avanti dall’AGI–Avvocati Giuslavoristi Italiani e dall’Associazione Nazionale Magistrati, che ha avuto maggiore successo, tanto da essere utilizzata come testo base dalla Camera dei deputati, che lo ha approvato nell’ambito della legge delega sulla riforma del processo civile.
Recente approvazione di progetto di abrogazione da parte della Camera dei deputati
Pur a fronte dell’abrogazione della normativa per l’avvenire, il testo di legge approvato nel 2016 mantiene in vigore la procedura, sino in cassazione, per i giudizi in corso alla entrata in vigore della legge.
La nuova previsione normativa mantiene inoltre in vita il calendario speciale relativo ai giudizi di impugnazione di licenziamenti rientranti nell’ambito dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che devono essere trattate con particolare speditezza, con vigilanza particolare dei dirigenti degli uffici giudiziari e sanzioni disciplinari in caso di inosservanza, consentendo, altresì, che le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non proposte con rito ordinario ex articolo 414 del codice di procedura civile, siano introdotte con i riti speciali, come l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, l’articolo 38 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (discriminazioni in tema di parità uomo donna) e l’articolo 28 della legge 220 del 21 Settembre 2011.
Il testo di legge approvato ritorna quindi nell’alveo della procedura di lavoro delineata nel 1973, ritenuta nuovamente idonea ad assolvere, pur con un calendario particolare, le cause di licenziamento di cui all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
È sintomatico verificare come la previsione adottata dal Parlamento, ai fini dell’invito alla trattazione con maggiore speditezza, continui a non distinguere tra domande che abbiano finalità reintegratorie e domande tendenti ad ottenere solo un’indennità economica, mentre sarebbe stato logico un distinguo, in relazione al tipo di domanda, rendendo legittimo chiedersi perché siano stati esclusi dal calendario i giudizi di impugnativa dei licenziamenti non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, quali ad esempio, quelli relativi a dipendenti di piccole aziende, i quali, pur se in termini ridotti, avrebbero egualmente diritto ad ottenere una celere accertamento in ordine alla legittimità o meno del recesso..
Non si è a tal uopo sufficientemente considerato che, ove la domanda sia proposta ai sensi dell’articolo 18, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori, l’intervento del giudice condurrebbe ad una condanna di tipo esclusivamente economico, al pari delle domande formulate per impugnative di licenziamenti a tutela obbligatoria o quelle relativa a licenziamenti effettuati dopo il 5 marzo 2015. Non si vede la ragione del mantenimento del diverso trattamento processuale.
È facile, comunque, prevedere che, anche con il calendario speciale, a meno di una non ipotizzabile contrazione delle cause di lavoro, non si raggiungeranno particolari risultati in termini di celerità, tenuto conto dell’improbabile aumento degli stanziamenti per strutture di giustizia.
Opportunità dell’introduzione norme prevedenti nuove forme di soluzioni conciliative
Ma anche ove si raggiungessero risultati nell’adozione di sentenze di primo grado, la domanda di celere giustizia risulterebbe sempre insoddisfatta, tenuto conto che l’interesse delle parti non ha mai ad oggetto soluzioni processualmente non definite e precarie, con possibilità di impugnative, opposizioni, reclami, appelli e ricorsi di legittimità ecc., ma soluzioni certe e tombali, raggiungibili solo con il celere raggiungimento di un giudicato o attraverso sistemi di composizione mediata dei conflitti.
Auspicato
In tal senso, per accelerare la soluzione dei problemi e dare speditezza alle vertenze di lavoro, la strada obbligatoriamente percorribile non può che essere quella del ricorso a forme di mediazione preventiva, nella quale assumano concreto protagonismo gli avvocati). Tali soluzioni non devono però essere alternative e facoltative, ma incentivate ed obbligate, sanzionandosi la mancata partecipazione alla trattativa e nelle quali le parti siano “ante causam” chiamate ad incontrarsi e a darsi atto in termini definiti delle reciproche posizioni, in ciò coadiuvate da previsioni di legge che definiscano con chiarezza i termini massimi e minimi entro cui raggiungere un accordo.
Sotto tale profilo si è rivelata positiva la previsione di cui all’articolo 1, comma 40, della Legge 28 giugno 2012, n.92, che, costringendo, per i licenziamenti cd economici, le parti a trattare sulla base di parametri definiti, ha consentito di deflazionare moltissimo il contenzioso, attraverso uno strumento che già ha visto chiudere, in via definitiva, decine di migliaia di casi. Sarebbe auspicabile che una simile procedura si attivasse anche per i licenziamenti per giusta causa e per i licenziamenti collettivi.
In tal senso si pone, significativamente, la stessa normativa sul Job’s Act, che, pur prevedendo, per gli assunti dopo il 7 marzo 2015, l’applicazione della procedura del lavoro ordinaria anche per le cause di impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e pur eliminando la convocazione preventiva prevista dall’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 (come modificato dalla Legge n. 92/2012), ha introdotto la facoltà per il datore di lavoro, dopo aver inviato la lettera di licenziamento, di formulare al lavoratore, nei termini dell’impugnativa, una offerta di conciliazione in una sede idonea, accompagnata da un assegno circolare per un valore coincidente al lordo di una mensilità pro anno, prevedendone la fruibilità, al netto, per il lavoratore.
Questa è certamente la strada giusta, posto che, non avendo potuto la procedura del lavoro trovare spazio per l’eccessivo contenzioso, è auspicabile che, riducendosi, in quanto definite in sedi esterne e con applicazione di indennità definibili in modo veloce e certo su parametri prestabiliti, le residuali vertenze di impugnativa di licenziamento non raggiungano numeri tali da impedire la veloce conclusione in sede giudiziale.
Nuovi spazi verrebbero peraltro ad aprirsi ove si desse effettivamente corso a forme di mediazione assistita anche in ambito di lavoro, con autorizzazione degli avvocati di “certificare” la consapevolezza dei propri clienti in ordine alle rinunzie compiute.
Va al riguardo segnalato che il progetto di riforma del codice di procedura civile, attualmente all’esame del parlamento, non esclude l’introduzione della “negoziazione assistita” per le cause di lavoro.
È quindi auspicabile che si incrementino procedure di conciliazione preventiva stragiudiziale che vedano coinvolti responsabilizzati in primis gli avvocati, i quali, in genere, avendo approfondito il caso, i documenti, e conoscendo le armi istruttorie a propria disposizione, conoscono perfettamente, nella valutazione dei rischi di causa, quale sia il giusto punto di caduta per un accordo transattivo.
Ove invero le parti, con i rispettivi avvocati, siano preventivamente obbligate a scoprire le carte ed a trattare sulla base delle stesse, anche manifestandosi formalmente le linee difensive e le ipotesi transattive proposte, sarebbe più agevole il raggiungimento stragiudiziale di un accordo, del quale i legali stessi si farebbero garanti, da favorirsi con forme di premialità fiscale.
Al giudice, che potrebbe decidere solo all’esito della formazione di un fascicolo contenente l’iter della trattativa preventiva, sarebbe rimesso quindi il solo celere compito di “fare giustizia”, con azione depurata dagli obbligatori, e spesso defatiganti, tentativi di conciliazione, affrancato per di più dall’imbarazzo della formulazione di ipotesi di accordo, in genere rese senza l’intervento mediatorio dei legali e solo sulla incompleta conoscenza dei fatti di causa, così come risultanti dalle posizioni, non sempre veritiere e tattiche delle difese di parte.
In conclusione, l’introduzione e abrogazione del “Rito Fornero” si è manifestata utile, se non altro, per sperimentare, sul campo, la tematica delle urgenze processuali e dei tempi della giustizia, nonché comprendere definitivamente l’inutilità dei tentativi solutori del problema con artifizi o modifiche meramente processuali.
- L’insubordinazione nel rapporto di lavoro e la funzione delle clausole disciplinari collettive: nota a Cass. Ord. n.6398 del 10 marzo 2025 - 26 Marzo 2025
- “Rito Fornero” sui Licenziamenti – Genesi storica ed inesorabile tramonto di una procedura inopportuna e poco amata - 22 Luglio 2016
- Licenziamento – Cassazione Lavoro: termini di decadenza e inefficacia dell’impugnazione comunicata prima dell’espletamento della procedura conciliativa - 12 Novembre 2015
- La Somministrazione transnazionale all’interno dell’Unione europea e gli adempimenti necessari alla fornitura del servizio all’interno del territorio italiano - 6 Novembre 2015